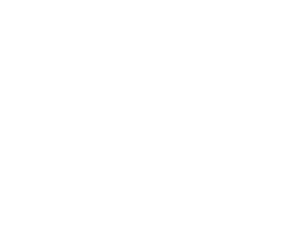L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), istituita con la Legge n. 470 del 27 ottobre 1988, è parte integrante dell’anagrafe italiana e contiene i dati di tutti i cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore a dodici mesi. È diritto-dovere di ogni cittadino italiano che si trasferisce per più di dodici mesi comunicare al Comune di ultima residenza e, entro novanta giorni dall’arrivo al Consolato/Cancelleria Consolare competente, l’avvenuto trasferimento. Il cittadino italiano con l’iscrizione all’AIRE ottiene il diritto di voto all’estero, può chiedere il rilascio/rinnovo dei documenti di identità (carta di identità e passaporto) ed esce dal sistema sanitario italiano, ovvero perde l’assistenza sanitaria di base in Italia, pur conservando quella per le emergenze ed il diritto, in alcuni casi, a ricevere cure mediche e ottenerne il rimborso (si veda il capitolo sanità).
Le persone nate all’estero ma che hanno acquisito la cittadinanza italiana per nascita o le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana all’estero devono ugualmente dare notizia all’AIRE della propria residenza. Non devono invece iscriversi all’AIRE coloro che si recano all’estero per soggiorni brevi o stagionali comunque di durata non superiore ai dodici mesi, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Gli iscritti all’AIRE sono tenuti a informare il Consolato competente di trasferimenti di Paese, cambio di indirizzo, modifiche dello stato civile (nascite, matrimoni, divorzi). Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della legge n. 1228 e n. 470 è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Per l’iscrizione all’AIRE o la variazione di indirizzo è possibile caricare la documentazione direttamente sul portale FAST-IT, lo strumento istituzionale interattivo creato per i cittadini italiani all’estero (link: https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco) o in alternativa, inviare la richiesta a mezzo posta (raccomandata di preferenza).
Gli elettori italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono altresì votare per l’elezione dei rappresentanti dei COMITES – Comitati degli italiani all’estero, purché siano residenti nella circoscrizione consolare da almeno sei mesi alla data delle elezioni.
Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia
Ufficio AIRE
5-7, rue Marie Adélaïde
L-2128 Luxembourg
Tel. (+352) 44 36 44 – 1 / (+352) 44 36 44-334
ambasciata.lussemburgo@esteri.it
consolare.lux@esteri.it
aire.lux@esteri.it